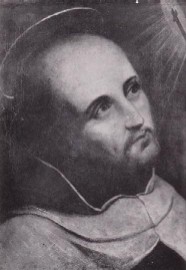Papa Benedetto XVI e la liturgia.
Del prof. Davide Ventura. Da: L\’eco dell\’eremo della Beata Vergine del Soccorso – Minucciano. Il valore del messale antico e il “Motu proprio” Summorum Pontificum. L’abbandono della bellezza. “Actuosa participatio”. Il problema della lingua liturgica. Versus orientem. Unità nella diversità.
Chiedersi questo non significa certo opporsi allo sforzo per far cantare tutto il popolo, opporsi alla «musica d\’uso»: significa opporsi a un esclusivismo (solo quella musica) che non è giustificato né dal Concilio né dalle necessità pastorali”. E ancora: “Una Chiesa che si riduca solo a fare della musica «corrente» cade nell\’inetto e diviene essa stessa inetta. La Chiesa ha il dovere di essere anche «città della gloria», luogo dove sono raccolte e portate all\’orecchio di Dio le voci più profonde dell\’umanità. La Chiesa non può appagarsi del solo ordinario, del solo usuale: deve ridestare la voce del Cosmo, glorificando il Creatore e svelando al Cosmo stesso la sua magnificenza, rendendolo bello, abitabile, umano”.
Come accenna il Papa, si sa che di solito si è dato a questa domanda la risposta pratica di moltiplicare e distribuire a quante più persone possibile i servizi paraliturgici durante la celebrazione: vi è chi accende le candele e chi le spegne, chi bada all’acqua e chi al vino, chi legge il profeta e chi l’epistola, chi canta il salmo e chi il Gloria; la preghiera dei fedeli deve vedersi alternare una persona diversa per ogni invocazione, e la processione dell’offertorio deve a volte somigliare a un corteo. Non così per il Papa. Continua il testo citato: “Con il termine «actio», riferito alla liturgia, si intende nelle fonti il canone eucaristico. La vera azione liturgica, il vero atto liturgico, è la oratio: la grande preghiera, che costituisce il nucleo della celebrazione liturgica e che proprio per questo, nel suo insieme, è stata chiamata dai Padri con il termine oratio. […]
Questa oratio – la solenne preghiera eucaristica, il «canone» – è davvero più che un discorso, è actio nel senso più alto del temine. In essa accade, infatti, che l’actio umana (così come è stata sinora esercitata dai sacerdoti nelle diverse religioni) passa in secondo piano e lascia spazio all’actio divina, all’agire di Dio. […] Ma come possiamo noi avere parte a questa azione? […] noi dobbiamo pregare perché (il sacrificio del Logos) diventi il nostro sacrificio, perché noi stessi, come abbiamo detto, veniamo trasformati nel Logos e diveniamo così vero corpo di Cristo: è di questo che si tratta”. Qui, all’interno della fornace ardente che è il centro stesso della fede cristiana, siamo realmente a miglia di distanza dalle interpretazioni sociologiche banalizzanti di cui si diceva. E infatti prosegue il Papa: “La comparsa quasi teatrale di attori diversi, cui è dato oggi di assistere soprattutto nella preparazione delle offerte, passa molto semplicemente a lato dell’essenziale. Se le singole azioni esteriori (che di per sé non sono molte e che vengono artificiosamente accresciute di numero) diventano l’essenziale della liturgia e questa stessa viene degradata in un generico agire, allora viene misconosciuto il vero teodramma della liturgia, che viene anzi ridotto a parodia”.
Nel testo sopra citato, il cardinal Ratzinger rivolge queste osservazioni a tali tesi, citando a sua volta e facendo proprio il testo di L. Bouyer “Architettura e liturgia”: “È evidente che in questo modo si è frainteso il senso della basilica romana e della disposizione dell’altare al suo interno. […] Cito in proposito, ancora una volta Bouyer: «Prima di quella data (cioè prima del secolo XVI) non abbiamo mai e da nessuna parte la benché minima indicazione che si sia attribuita qualche importanza o solo anche qualche attenzione al fatto che il presbitero celebrasse con il popolo davanti a sé oppure dietro a sé. Come ha dimostrato Cyrille Vogel, l’unica cosa su cui si sia veramente insistito e di cui sia fatta menzione è che egli doveva dire la preghiera eucaristica, al pari di tutte le altre preghiere, rivolto verso oriente … Anche quando l’orientamento della Chiesa permetteva al celebrante di pregare rivolto verso il popolo allorché era all’altare, non era solo il presbitero a doversi volgere verso oriente: era l’assemblea intera che lo faceva insieme a lui”.
Nel citato libro-intervista “Rapporto sulla fede” leggiamo: “La Messa non è solamente un pasto tra amici, riuniti per commemorare l\’ultima cena del Signore mediante la condivisione del pane. La messa è il sacrificio comune della Chiesa, nel quale il Signore prega con noi e per noi e a noi si partecipa. È la rinnovazione sacramentale del sacrificio di Cristo”. La presenza reale del Signore nelle specie consacrate genera poi del tutto legittimamente forme di culto eucaristico anche esterne al rito della Messa: “Si è dimenticato che l\’adorazione è un approfondimento della comunione. Non si tratta di una devozione «individualistica» ma della prosecuzione o della preparazione del momento comunitario. Bisogna poi continuare in quella pratica, così cara al popolo (a Monaco di Baviera, quando la guidavo, vi partecipavano decine di migliaia di persone) della processione del Corpus Domini. Anche su questa gli «archeologi» della liturgia hanno da ridire, ricordando che quella processione non c\’era nella Chiesa romana dei primi secoli. Ma ripeto qui quanto già dissi: al sensus fidei del popolo cattolico deve essere riconosciuta la possibilità di approfondire, di portare alla luce, secolo dopo secolo, tutte le conseguenze del patrimonio che gli è affidato”.
Lo stesso Pontefice lo spiega nella lettera di accompagnamento al motu proprio Summorum Pontificum scritta ai vescovi: “Le due forme dell’uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione «Ecclesia Dei» in contatto con i diversi enti dedicati all’«usus antiquior» studierà le possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all’antico uso. La garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa unire le comunità parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale”.
La evoluzione “organica” delle due forme del rito romano deve dunque, per il Papa, riprendere di nuovo. Ed esse possono influenzarsi a vicenda: la forma tradizionale dovrà compiere gli aggiornamenti minimali (ad esempio circa il calendario liturgico) richiesti dal suo essere rimasta cristallizzata per quarantacinque anni. E soprattutto la forma riformata potrà e dovrà riconoscere nella forma antica un polo di attrazione, una norma a cui ispirarsi per tornare gradualmente nell’alveo della medesima evoluzione organica da cui gli anni della sperimentazione estrema l’avevano fatta uscire.
Riportiamo una bibliografia essenziale dei libri pubblicati dall’attuale Pontefice, dandone l’edizione italiana consultata. Le citazioni nel testo, per quanto estese, non fanno ovviamente giustizia a un pensiero vasto e articolato, in cui il tema liturgico ricorre di frequente, a volte anche intrecciato insieme ad altri argomenti. Laddove possibile, un accesso diretto a tali opere è quindi insostituibile.
La festa della fede – Jaca Book – 1984
Rapporto sulla fede – Edizioni Paoline – 1985
Il sale della terra – San Paolo – 1997
Introduzione allo spirito della liturgia – San Paolo – 2001
Il Dio vicino – San Paolo – 2003
La comunione nella Chiesa – 2004
La fraternità cristiana – Queriniana – 2005
Fede, verità e tolleranza – Cantagalli – 2005
L’Europa di Benedetto – Cantagalli – 2005
Ragione e fede in dialogo – Marsilio – 2005
(prefazione a) Uwe Michael Lang – Rivolti al Signore – Cantagalli – 2006
AMDG et DVM